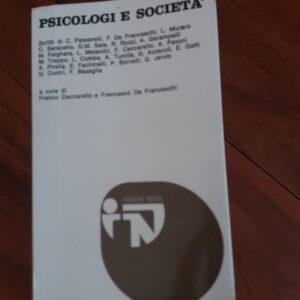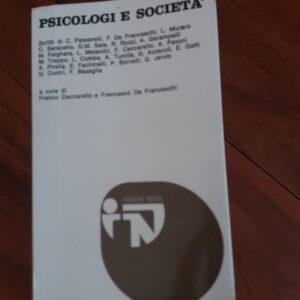Ph.Antonella Aresta
Luglio e gennaio sono mesi facili da decifrare. Potrebbero essere piccoli assaggi di eternità, per quanto sono definiti e immutabili, eguali a se stessi dall’inizio alla fine. Settembre no, dal primo giorno all’ultimo il mondo intorno a noi prende a cambiare. Settembre è il campo di una battaglia malinconica. L’esito è scontato e l’autunno prevarrà, ma la battaglia è comunque vera. Un giorno la pioggia può prenderti a schiaffi finché non trovi una tettoia per ripararti, la mattina dopo ti svegli e il sole ti morde la pelle.
G.Simi, Senza dirci addio, ed.Sellerio, 2022, Ed.del kindle, p.236
L’Ordine nazionale degli psicologi italiani ha votato la modifica del proprio codice deontologico, con 9.034 voti favorevoli e 7.617 contrari.
L’articolo 32 della Costituzione italiana recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Le modifiche del codice deontologico degli/lle psicologi/ghe riguardano l’articolo 24, sul consenso informato sanitario dinanzi a persone adulte capaci, e l’articolo 31, sul consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci.
La modifica del codice prevede la maggiore libertà delle/gli psicologhe/i che potranno segnalare direttamente all’autorità giudiziaria la necessità di un trattamento sanitario obbligatorio (Tso), anche senza il consenso informato.
Ricordo che l’attivazione del Tso prevede oggi tre variabili: 1. la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici; 2. gli interventi proposti vengono rifiutati; 3. non è possibile adottare tempestive e idonee misure extraospedaliere.
E oggi capita spesso che il provvedimento di ricovero forzato venga mantenuto, nonostante il paziente accetti la terapia.
Con l’aggiunta prevista nel codice, non saranno più necessari due pareri medici, l’ordinanza del sindaco, convalidata dall’autorità giudiziaria entro 48 ore; infatti: «Nei casi di assenza in tutto o in parte del consenso informato, ove la psicologa e lo psicologo ritengano invece che il trattamento sanitario sia necessario, la decisione è rimessa all’autorità giudiziaria».
Ricordo la storia. Nel 1978, la legge 180 sostituisce la legge Giolitti sulla custodia e la cura degli alienati. Nello stesso anno, Franco Basaglia, intervistato dal giornalista Giliberto del quotidiano La Stampa, commentava perplesso:
“E’ una legge transitoria, fatta per evitare il referendum, e perciò non immune da compromessi politici. Ora bisognerà lottare perché nella discussione sulla riforma sanitaria tanti aspetti farraginosi, ambigui, contraddittori di questa legge siano portati alla ribalta e cambiati… Ma attenzione alle facili euforie. Non si deve credere d’aver trovato la panacea a tutti i problemi dell’ammalato di mente con il suo inserimento negli ospedali tradizionali. La nuova legge cerca di omologare la psichiatria alla medicina, cioè il comportamento umano con il corpo. È come se volessimo omologare i cani con le banane. Facciamo l’esempio di chi ha un tumore o una febbrona o il verme solitario. Se va a finire all’ospedale, c’è la ricerca della causa del suo male, e in certi casi il ricovero s’impone (malattie molto contagiose). Ma se ricoveri – cioè togli la libertà – a una persona perché ha pensieri bizzarri o disturbi psichici, perché lo fai? A che cosa si riferisce quel ricovero? Che cosa può voler dire grave alterazione psichica? Negli ospedali ci sarà sempre il pericolo dei reparti speciali, del perpetuarsi di una visione segregante ed emarginante.”
Mi preoccupa l’ipotesi della consegna del potere alle/i colleghe/i che potranno imporre qualsiasi trattamento psicologico, nei tribunali e nelle scuole soprattutto, rischiando di farle diventare, “istituzioni dell’emarginazione”. (Ceccarello e De Franceschi, redattori degli atti del convegno di seguito citato)
La tentazione è di medicalizzare i malesseri sociali e i fenomeni dolorosi che originano nella storia culturale e nelle politiche sociali degli ultimi quarant’anni.
In origine, due erano le sedi della facoltà di Psicologia, a Roma e a Padova, e mi laureai nell’Università romana, dopo un percorso quadriennale che ne anticipò un altro quinquennale, di specializzazione. Rimasi otto/dieci anni, nei corridoi della scuola privata, fra l’analisi personale, gli esami anche con docenti americani, gli studi e le ricerche, le prime attività riportate in supervisione.
Mi convincevano e seguivo i movimenti non autoritari degli anni ’70 e ’80 e conoscevo le tre S del potere che ricattano e manipolano gli esseri viventi: il sesso, i soldi, il sapere; e io ne avevo aggiunta una quarta, la salute. Ancora oggi, nella società patriarcale, vince, ha successo, può contare ed essere felice chi ha più soldi, più salute, più virtù virili e più sapere.
La conoscenza può essere uno strumento di potere aggressivo se non viene trasformata da un orientamento che benedica e agevoli il sapere comunitario. La conoscenza condivisa prevede la responsabilità pedagogica, la reciprocità costitutiva di ogni essere umano. E, come psicologa, l’impegno più faticoso è riconoscere e assumerne al cinquanta per cento, la responsabilità dei tempi, delle modalità e degli strumenti differenti di apprendimento, mio e altrui. La psicologia accompagna verso un sapere comune e non può proporsi con modelli patriarcali, interpretando, suggerendo, risolvendo e detenendo il potere della competenza; deresponsabilizzando, di fatto, l’altro. Ritorno alla lettura del testo illuminante di Rebecca Solnit, Gli uomini mi spiegano le cose.
Dico, la cultura della psicologia patriarcale mi spiega come sto combinata e mi guarisce; se non collaboro, mi isola. E considero una involuzione pericolosa pensare che i comportamenti violenti sempre più diffusi possano essere ricondotti alla patologia e ridotti a malattie da controllare e da curare.
Il ruolo della/o psicologa/o non può essere strumentalizzato da parte di una politica in cerca di capri espiatori, di vittime sacrificali; non può essere utilizzato come una copertura di controllo, di ordine e di sicurezza. Psicologhe e psicologi dappertutto, certo, vigilando sulle derive possibili derivanti dal potere ricevuto come un dono, come una concessione che, nella realtà, rivela l’inganno della delega e della deresponsabilizzazione del sistema. Nel contesto di quali modelli culturali lavoriamo? E con quanti anni di analisi personale come garanzia minima di individuazione e di resistenza dinanzi alle manipolazioni di un sistema corrotto e che corrompe?
Attenzione a noi psicologhe e psicologi e ai peccati di ingenuità che divengono abusi: il rischio è fare un favore al modello patriarcale, è ripristinare i manicomi, stipare più persone in carcere, compresi i minori che delinquono, controllare in modo autoritario e repressivo, intervenire per irregimentare, isolare con la scusa della cura. Spesso il disagio psichico è l’iceberg di una causa originaria che riporta ad una più ampia visione antropologica da studiare e da trasformare.
Il fallimento di quella psicologia che propone di curare e di normalizzare è la ragione ed è il segno che rimandano al suo significato più profondo. Una volta discesi nella relazione, rimaniamo con l’altro nella zona oscura che permette lo sguardo luminoso per entrambi, ritrovando l’habitus della trascendenza. Lo spazio in negativo, che la psicologia offre, esprime la sua potenza quando spezza il rumore, quando confida nel silenzio e nella durata, quando motiva le idee trasformative. Le forze deboli sono tenaci e potenti rispetto alle influenze da social network e ai grandi canali di persuasione collettiva. La forza, anche espressiva, ci raggiunge nella significatività, non nei numeri di successo. Nella relazione psicologica, la fragilità, lo spazio angusto, l’irrisoluzione, il tempo sospeso, sono segnali di irriducibile capacità di comprensione. Fuori dalle regole del regime dominante, lo spazio e il tempo si restringono, ma acquistano valore. L’essenziale è cosa silenziosa e minuscola, favorisce i pensieri e le azioni alternative, liberando l’intuizione e operando in favore della collettività.
La psicologia è politica occupandosi di relazioni, riconoscendo e opponendosi alle situazioni simbiotiche, manipolative, parassitate. Quando interagiamo con coscienza e consapevolezza, non perseguiamo l’autosufficienza del singolo, partecipiamo al cambiamento del mondo, creiamo storie nuove individuali e collettive, organizziamo i ricordi e le esperienze e ridecidiamo, assieme. Ogni persona è l’oggetto e il soggetto nelle interazioni di reciprocità e non è la proiezione della fantasia narcisistica altrui. Penso alla necessità di una seria politica culturale di contestazione e di critica al sistema dell’emarginazione sociale postcapitalistica.
Negli anni della mia primaria formazione mi ero allontanata, piccata dagli interventi che avevo letto, dieci anni più tardi, di Luisa Muraro e di Lea Melandri, nella raccolta degli atti del Convegno di psicologia, tenutosi a Padova nel maggio 1973. Leggevo in quegli scritti i tentativi di sabotare la mia figura di giovane psicologa, che già vivevo come subalterna, indefinita, ambigua. Ma oggi, ritorno con sgomento, al pericolo che sottolineavano, cinquanta anni fa, soprattutto, le due studiose.
Le modifiche dell’ordinamento sono legittime, e la loro utilità per la giustizia sociale dipendono dagli equilibri, dai limiti, dalla formazione professionale, dall’analisi e dall’autoanalisi personale continua di ogni psicologa/o.
La psicologia non può diventare “una specie di superverità che libera tutti dalla responsabilità di decidere su ciò che è giusto e ciò che non lo è: lo psicologo, in quanto si limita ad enunciare la verità, gli altri perché non possono che prenderne atto. È la conferma più palese della deresponsabilizzazione generale.” Lea Melandri, pp.91/92
E Luisa Muraro, a pag.33:
“Di una cosa sono certa: è vero che il sapere psicologico è elaborato, trasmesso e usato contro di noi, contro quelli tra noi che non si conformano a modelli sociali, per sistemarci e classificarci a seconda: in ospedale, in manicomio, oppure per recuperarci per la famiglia e la fabbrica; questo riesce e funziona non tanto a partire da certe idee, ma a partire da una divisione tra competenti e incompetenti… è questa divisione che lascia sprovveduti e disarmati di fronte alla decisione sociale di emarginare, di fronte alla interpretazione delle differenze di comportamento come deviazioni pericolose da curare (il bambino che non sta fermo a scuola è malato, la donna che non sopporta i figli è malata, ecc.) (…) Non basta riconoscere che la “devianza” è una obiezione politica e umana contro questa società. Bisogna anche vedere attraverso quale meccanismo i reali problemi dei rapporti umani, le reali sofferenze di molti individui, le situazioni oppressive che ci fanno dare di matto o semplicemente i comportamenti singolari insoliti, per quale meccanismo tutto questo ci separa… Io voglio capire quel che mi succede, e quello che succede a quelli che mi sono vicini, questo sapere non può stare in mano ad altri.”